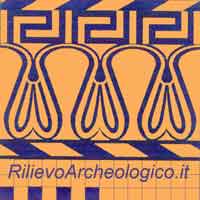 |

|
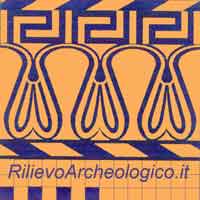 |

|
|
|
Lo scopo del rilievo è quello di misurare le dimensioni di uno o più manufatti per darne una rappresentazione esatta. Nella tradizione di questa disciplina la restituzione di un oggetto si basa sul metodo delle proiezioni ortogonali e si distinguono fondamentalmente due tipi di rappresentazioni grafiche: la pianta e il prospetto. La prima è una veduta zenitale che serve a descrivere l’oggetto nella sua estensione rispetto a un piano orizzontale; il secondo è una veduta laterale che proietta l’oggetto su un piano verticale (fig. 1).
La pianta descrive comunemente la faccia superiore del manufatto. Di un fabbricato mostra ad esempio le terrazze di copertura oppure le falde del tetto spiovente. Questo tipo di rappresentazione viene definito pianta dall’alto. Nella prassi del rilievo architettonico è più importante però documentare l’interno di un edificio, cioè i suoi vari piani o livelli. In questo caso il punto di vista della pianta corrisponde a un piano secante il quale può essere paragonato a una lama che taglia in orizzontale il manufatto a una determinata quota altimetrica stabilita da chi effettua il rilievo (fig. 2). Nel disegno viene riportato il contorno di tutti gli elementi tagliati dal piano di sezione — nel caso di un edificio ne risulterà il profilo dei muri divisori dei vari ambienti e dei muri perimetrali — , si rappresentano inoltre gli oggetti visibili al di sotto di esso — ad esempio la trama del pavimento, le soglie, i davanzali. Ciò che invece si trova al di sopra del piano secante non viene raffigurato. L’ingombro delle strutture sezionate viene di solito campito con delle linee diagonali (più nella prassi del rilievo architettonico che nel rilievo archeologico) e si dà un grosso spessore alla linea di contorno in modo da farla risaltare nettamente rispetto agli oggetti sottostanti visti in proiezione.
Allo stesso modo una rappresentazione verticale può essere dall’esterno e riprodurre una delle facce laterali del manufatto — per esempio la facciata di un edificio - oppure può darci una veduta dell’interno. In quest’ultimo caso il punto di vista coincide con un piano secante verticale (fig. 3). Nel disegno si riporta il profilo delle strutture sezionate — muri e solai nel caso di un edificio - anche in questo caso con un segno più marcato ed eventualmente la campitura a linee oblique dell’ingombro. Vengono inoltre proiettati tutti gli elementi verticali situati sullo sfondo, visibili dal piano secante in una delle due direzioni — ad esempio le porte, le finestre, le decorazioni parietali . Gli elementi che si trovano dalla parte opposta non potranno ovviamente essere considerati nello stesso disegno.
Il termine sezione indica la rappresentazione degli oggetti che sono attraversati dal piano secante; nella prassi viene utilizzato per le sole rappresentazioni verticali. Il prospetto è la restituzione grafica degli oggetti che sono proiettati sul piano verticale corrispondente al punto di vista, che può essere sia esterno sia interno (quindi secante) al manufatto. Nella documentazione degli interni i due tipi di restituzione sono generalmente abbinati in uno stesso disegno che viene pertanto denominato sezione-prospetto (fig. 3). Si usa sempre il termine prospetto per le rappresentazioni dei lati esterni degli edifici (fig. 1). Nel caso delle planimetrie quando il piano di proiezione è situato sopra il manufatto si parla di pianta dall’alto o a volo d’uccello (fig. 1), se invece è secante si usa la definizione di pianta sezionata, oppure di pianta del primo (o secondo, o terzo, ecc.) livello (fig. 2). Nel campo del rilievo archeologico è buona regola menzionare la quota altimetrica del piano di sezione orizzontale, per cui si dirà ad esempio pianta a quota m. 52 s.l.m.
Chi organizza un rilievo deve stabilire quante e quali piante, prospetti e sezioni-prospetto sarà necessario produrre. Dovrà quindi decidere le quote altimetriche dei piani orizzontali di sezione nonché la posizione e l’orientamento dei piani di proiezione verticali, sia esterni che secanti. Per quanto riguarda la documentazione planimetrica, nel caso di un edificio allo stato di rudere, i cui alzati si conservano per poche decine di centimetri risulterà sufficiente una pianta dall’alto (fig. 12). Nel caso di edifici integri o di cui si siano preservati, anche parzialmente, almeno due piani oppure il pian terreno e il solaio soprastante, sarà invece opportuno realizzare più di una pianta. La consuetudine del rilievo architettonico richiede l’esecuzione di una planimetria per ogni livello, oltre eventualmente a una pianta a volo d’uccello in cui figurino le coperture. Ciascuna sezione orizzontale va collocata a una quota che consenta di riportare i profili degli elementi più significativi di quel piano. Solitamente si cerca di impostarla sopra i davanzali delle finestre e sotto gli architravi delle porte (ad esempio a m. 1,50 sopra il pavimento in edifici di normali dimensioni) in modo da poter documentare entrambi i tipi di aperture, riportando nel disegno sia la sezione delle spalle sia la proiezione dei davanzali e delle soglie (figg. 2, 4). Il posizionamento della sezione orizzontale a questo livello si presta anche per documentare eventuali nicchie alle pareti le quali negli edifici storici, nella maggior parte dei casi, stanno più o meno in quota con le finestre. Non è infrequente tuttavia che all’interno di un ambiente alcuni elementi architettonici si trovino a una quota completamente difforme rispetto agli altri e che quindi siano destinati a restare al di sopra del piano di sezione. Altri elementi possono trovarsi invece al di sotto del piano secante ma non sono proiettabili in quanto capitano interamente all’interno dell’ingombro del muro sezionato. Il primo caso può essere ad esempio quello di una finestrella o di una mensola situate sotto la volta, il secondo quello di una piccola nicchia ricavata nel muro, subito sopra il pavimento. In entrambe le ipotesi si potrà restituire il profilo di tali elementi con una linea tratteggiata. Si avrà cura possibilmente di utilizzare trattini di dimensioni diverse per distinguere i contorni al di sopra del piano di sezione da quelli al di sotto (più brevi in questo caso) e di darne conto in legenda (fig. 4).
Nei rilievi architettonici si proiettano sulla pianta con linee a tratteggio anche le volte. Quelle a crociera sono indicate da due linee diagonali che si incrociano al centro, corrispondenti alla proiezione delle unghie. Le volte a botte vengono segnalate ribaltandone sulla pianta, a fianco dei muri che stanno sotto le lunette, il profilo dell’intradosso (fig. 4). Nelle piante archeologiche, nei casi in cui le pavimentazioni degli ambienti sono ricche di dettagli, si preferisce omettere questi segni; la morfologia delle coperture sarà mostrata in ogni caso nelle sezioni-prospetto.
Il percorso delle sezioni verticali viene indicato sulle piante con una linea a tratto-punto con due frecce alle estremità che indicano la direzione della vista (fig. 4). Le sezioni vengono solitamente denominate con una coppia di lettere (A-A’; B-B’; ecc.) che vengono riportate sulla pianta in prossimità delle due frecce. Una stessa sezione può essere utilizzata per produrre due differenti elaborati: in uno di questi saranno riportate le proiezioni di tutti gli elementi appartenenti a una delle due metà dell’oggetto sezionato — ad esempio i contorni delle porte del lato sinistro di una stanza -; nell’altro disegno sulla medesima sezione si riportano le proiezioni degli elementi appartenenti alla metà opposta dell’oggetto — le porte del lato destro della stessa stanza. Una sezione di questo genere viene segnata sulla pianta con due coppie specchiate di frecce le quali indicano gli opposti punti di vista.
La documentazione completa di un edificio richiederebbe l’esecuzione di tutti i prospetti esterni e sezioni interne per ogni fila di ambienti, specchiate e orientate sia in senso longitudinale che in senso trasversale. Si tratta di un lavoro molto impegnativo che comporta una produzione di elaborati assai più copiosa e generalmente più ricca di dettagli rispetto alle planimetrie. La mancanza di tempo e di risorse obbliga nella maggior parte dei casi a limitare il numero delle vedute verticali. Chi effettua un rilievo deve pertanto fare una scelta, valutando quali sono i prospetti e le sezioni-prospetto maggiormente rappresentativi per descrivere l’edificio e a quali vedute si potrà rinunciare. Ad esempio se abbiamo un muro che su un lato presenta delle nicchie e una fila di fori da incasso, mentre sul lato opposto non si vede alcun elemento architettonico significativo e la tessitura del paramento in opera laterizia è uguale in entrambi i lati, sarà sufficiente documentare solo la faccia con le nicchie. Ai fini di una maggiore chiarezza del disegno è opportuno proiettare sulla sezione solo gli oggetti che si trovano in primo piano, i quali cioè appartengono all’ambiente sezionato, evitando la rappresentazione di muri pertinenti ad ambienti situati in secondo piano e oltre che si intravedono attraverso una porta o alle spalle di una parete diruta. Di un muro molto più alto situato in secondo piano si può eventualmente indicare l’ingombro con una linea di contorno. Ma se intendiamo documentarne tutti i particolari è più corretto impostare, in aggiunta alle altre, una sezione-prospetto che gli passa vicino.
I piani di proiezione verticali, sia esterni che interni, devono essere paralleli alle pareti da rappresentare. Se invece il piano di proiezione è divergente, la parete, essendo proiettata in senso ortogonale a quello, nel disegno risulterà più corta. Bisogna fare i conti con il fatto che gli edifici storici hanno spesso una pianta irregolare; i vari segmenti dei muri interni possono presentare diversi orientamenti. Può capitare inoltre che i muri perimetrali non siano ortogonali alla parete interna che vogliamo rappresentare in prospetto, così se il nostro piano di proiezione si mantiene parallelo a quest’ultima, il muro esterno sarà sezionato in modo sghembo e nel disegno risulterà uno spessore maggiore rispetto alla misura reale. Il percorso delle sezioni interne dovrà adeguarsi per quanto è possibile ai cambiamenti di direzione delle pareti. Una sezione verticale che attraversa un edificio storico da parte a parte è talvolta costituita da una concatenazione di piani di proiezione diversamente orientati che in pianta saranno indicati con una linea spezzata a tratto-punto (fig. 4 sezione TT’). Allo scopo di tagliare e quindi rappresentare in modo adeguato determinati elementi architettonici particolarmente significativi può inoltre essere necessario in certi casi prevedere delle riseghe (baionette) sul percorso della sezione (fig. 4 a, b). I punti in cui la sezione cambia orientamento oppure dà luogo a una baionetta vengono indicati sul grafico della sezione-prospetto con delle linee a tratto-punto verticali (fig. 5 a, b).
Le sezioni dovrebbero passare preferibilmente al centro degli ambienti. Questa collocazione consente di tagliare la maggior parte delle finestre, le quali si trovano più frequentemente sull’asse centrale della stanza, illustrandone l’articolazione interna. Nel caso in cui vi siano coperture a volta la sezione al centro ne garantisce la rappresentazione più corretta: la volta va infatti sezionata in chiave per valutarne lo spessore e per vedere in proiezione una delle due metà dell’intradosso.
Naturalmente siccome l’articolazione degli edifici storici è in genere assai complessa, in alcuni casi sarà necessario compiere dei compromessi rispetto alle indicazioni operative sopra proposte. Un numero esagerato di baionette e cambiamenti di orientamento può risultare fastidioso e generare un senso di confusione. Proiezioni ortogonali di pareti divergenti talvolta sono inevitabili e possono anzi tradurre in modo più efficace l’articolazione interna dell’edificio. Vari fattori, ad esempio la presenza di ostacoli visivi, potrebbero sconsigliare il passaggio della sezione al centro dell’ambiente e far preferire un percorso tangente alla parete da rappresentare. Si consideri anche il caso delle superfici curvilinee (esedre, volte a botte) le quali, se sono ricche di importanti dettagli, meritano di essere riprodotte nella loro estensione proiettandole su una sezione ad andamento semicircolare tangente alle stesse (fig. 6). Ciò che conta più di ogni altra cosa in definitiva è la capacità di ragionamento dell’operatore, il quale dovrà trovare le soluzioni più idonee per rappresentare in maniera comprensibile ed esauriente il contesto del suo rilievo.
Fra i tipi di rappresentazioni grafiche si comprendono anche l’assonometria e la prospettiva (fig. 7). Entrambe hanno la proprietà di mostrare varie facce dell’oggetto — ad esempio la pianta e due lati verticali — dandone una rappresentazione più completa e intelligibile. L’assonometria è una proiezione parallela (gli elementi del disegno sono proiettati con linee parallele su un piano che può essere diversamente orientato) e ha il vantaggio di fornire una visione tridimensionale in cui sono misurabili tutte le parti visibili del manufatto. La prospettiva è una proiezione conica (le linee di proiezione convergono verso il punto di vista) che restituisce una visione tridimensionale conforme a quella dell’occhio umano. Le due rappresentazioni sono il prodotto di una elaborazione posteriore che utilizza le piante e i prospetti restituiti dal rilievo. Una volta si disegnavano a tavolino per mezzo di costruzioni geometriche, adoperando riga e squadre. Oggi queste vedute si ottengono da modelli tridimensionali vettoriali costruiti al computer con metodologie di cui si parlerà nella seconda parte del testo.
La scala indica il rapporto tra le dimensioni dell’oggetto reale e le dimensioni dell’oggetto disegnato. Il rapporto di riduzione si esprime con una frazione. Scala 1:50 significa ad esempio che un segmento lungo un centimetro nel disegno corrisponde a cinquanta centimetri reali. Quando il denominatore è un numero grande — ad esempio nel rapporto 1:25.000 che è utilizzato per la rappresentazione del territorio — si parla di rilievo o di grafico a piccola scala. Quando viceversa il denominatore è un numero piccolo — ad esempio nel rapporto 1:2 utilizzato per la rappresentazione in dettaglio di un oggetto — si usa la definizione di rilievo o grafico a grande scala.
La scelta della scala è condizionata dalle dimensioni del contesto da documentare e influisce sul livello di dettaglio del disegno. La documentazione archeologica considera gli ambiti più disparati — piccoli oggetti, saggi di scavo, edifici, porzioni del territorio — per cui nel nostro campo si usa ogni tipo di scala. Sono indicati qui di seguito i rapporti di riduzione maggiormente utilizzati nel rilevo archeologico in relazione ai vari contesti e le rispettive modalità di rappresentazione.
La scala 1:1 si usa per la rappresentazione di piccoli oggetti, i quali vengono rilevati usando il pettine (la ceramica), a contatto (piccole porzioni di mosaici e di pitture parietali, campioni di paramenti murari) oppure con il sistema del frottage (monete, iscrizioni), tecniche di cui tratteremo nel capitolo sul rilievo diretto.
Per quanto riguarda la ceramica, i vasi integri o quasi integri sono rappresentati con il corpo diviso in due metà da una linea verticale centrale: a sinistra si disegnano la sezione e il prospetto della superficie interna del vaso, a destra si mostra in prospetto l’esterno (fig. 8 A). Dei frammenti si danno un prospetto e una sezione collocati in quota (B, C). Quando la forma originaria del vaso è riconoscibile il frammento viene inserito all’interno di una ricostruzione grafica redatta con lo stesso criterio che si usa per i vasi integri (D).
Il rilievo della decorazione architettonica dei monumenti antichi ha alle spalle una insigne tradizione che inizia con i maestri del Rinascimento. L’interesse si concentrava soprattutto sugli ordini, costituiti dalle colonne con le relative trabeazioni, i quali erano studiati e presi a modello per la progettazione dei nuovi edifici. In molte rappresentazioni dei secoli passati si faceva largo uso di ombreggiature realizzate con fitte trame di linee. Il più alto livello formale si raggiunge nelle immagini del XIX secolo ove il trattamento grafico crea effetti plastici di grande eleganza e realismo. Molti disegni inoltre non rappresentavano le lacune degli elementi rilevati ma erano delle vere e proprie ricostruzioni (cfr. App. fig. 126). Il rilievo archeologico moderno predilige le linee nitide che evidenzino senza ambiguità l’esatto contorno dei motivi decorativi e soprattutto rendano conto dell’effettivo stato di conservazione dei manufatti. Alcuni autori fanno ancora oggi uso di ombreggiature ma in maniera meno invasiva, con sfumature o puntini che traducono efficacemente l’articolazione plastica dell’oggetto senza togliere il necessario risalto alle linee di contorno . Rispetto al passato si dà soprattutto maggiore attenzione alle spaccature e alle abrasioni delle superfici le quali fanno parte della storia del pezzo e contribuiscono a farci intendere non solo la sua originaria collocazione ma anche le vicissitudini del reimpiego (fig. 9).
Nella impostazione del rilievo occorre distinguere tra gli elementi in situ (o in giacitura primaria), quelli in posizione di crollo (giacitura secondaria) e quelli erratici. Nei primi due casi gli elementi andranno rilevati nel loro contesto, inseriti nella rappresentazione dell’edificio o in quella dello strato messo in luce dallo scavo, per solito in scala 1:20 o 1:50. In aggiunta si potranno prevedere delle tavole in scala più grande per i singoli elementi architettonici allo scopo di evidenziarne i particolari, secondo gli stessi criteri adottati per la documentazione dei blocchi e dei frammenti fuori contesto, conservati nei musei e nei magazzini. In questi casi la scelta della scala dipenderà dalla dimensione del pezzo, dal tipo di decorazione e dai vari dettagli che sarà necessario riprodurre. Dei blocchi architettonici si dà almeno una sezione e si rappresentano in pianta e in prospetto non solo le facce decorate ma anche quelle che restavano nascoste se recano tracce significative che fanno comprendere il rapporto con le strutture circostanti: riseghe, incassi, anathyrosis, ecc. Nelle facce non rifinite si documentano le impronte degli strumenti utilizzati per la lavorazione in cantiere, come ad esempio le asce-martello, i punteruoli e le gradine che lasciano sulla pietra dei segni molto caratteristici. Ugualmente importanti sono le tracce degli attrezzi che furono impiegati per tagliare il pezzo a fini di riuso.
Nelle ricostruzioni grafiche degli ordini architettonici i frammenti che si sono conservati - e che sono stati rilevati - vengono collocati nella loro posizione originaria e fatti risaltare rispetto al resto del disegno.
La scala 1:10 viene utilizzata anche per il rilievo delle sepolture, particolarmente per quelle a fossa, tipologia che ha una grandissima diffusione sul territorio. Gli scavi di questi ultimi anni eseguiti nel Suburbio di Roma hanno comportato l’esecuzione di centinaia di rilievi che documentano tombe a fossa scavate nel terreno tufaceo o argilloso e le relative deposizioni. L’elaborato grafico di ciascuna tomba comprende una pianta per ogni livello stratigrafico significativo e una sezione cumulativa, solitamente posizionata sull’asse longitudinale della fossa, in cui è riportato il profilo dei vari strati scavati (fig. 10). Al livello superiore si trova il più delle volte una copertura di tegole messe di piatto oppure a spioventi (a cappuccina). Al livello sottostante viene rappresentato lo scheletro dell’inumato che talvolta è accompagnato da uno o più oggetti del corredo funebre. Una terza e ultima pianta documenta eventualmente il fondo della fossa.
Il livello di dettaglio della scala 1:10 è elevatissimo e molto realistico. Delle tegole, che spesso si presentano spezzate in frammenti variamente inclinati, si riportano le alette, le lesioni, le proiezioni delle varie facce. Il rilievo della deposizione richiede una notevole padronanza e conoscenze anatomiche. Si disegnano tutte le ossa, anche le più piccole.
2.4 La scala 1:20. Saggi di scavo e piccoli edifici. Documentazione dello scavo. Lettura stratigrafica della parete. Caratterizzazione
Questo rapporto (in alternativa alcuni preferiscono quello 1:25) viene adottato per la documentazione dei saggi di scavo e degli edifici di piccole dimensioni. La metodologia del rilievo si adegua a quella dello scavo archeologico il quale si fonda sulla individuazione di singoli strati (o unità stratigrafiche) ciascuno dei quali viene scavato e documentato separatamente dagli altri. Ogni strato si è formato in conseguenza di un determinato evento, sia naturale (ad esempio un deposito di limo causato da un’alluvione) sia artificiale (un accumulo di rifiuti, lo scavo di una buca, la costruzione di un muro); si distingue dagli altri per la composizione, la consistenza e il colore e deve essere riconosciuto dall’archeologo in fase di scavo. Gli strati possono essere porzioni di terreno più o meno ricco di materiali o strutture murarie. La maggior parte hanno un volume che è stato creato da un’azione positiva (accumulo, deposito, costruzione); altri sono il risultato di un’azione negativa — si definiscono pertanto unità stratigrafiche negative — che ha comportato l’asportazione di materia (scavi, sbancamenti, spoliazioni) e appaiono come superfici (tagli) le quali vanno documentate come le unità positive. La stratigrafia corrisponde pertanto a una successione temporale di eventi. Lo scavo archeologico smonta uno dopo l’altro i singoli pezzi che compongono la storia di un determinato luogo procedendo all’indietro nel tempo; si scavano e si documentano prima gli strati più recenti situati in alto, poi quelli antecedenti scendendo gradualmente in profondità. L’archeologo deve saper riconoscere i rapporti cronologici tra i vari strati (stratigrafia relativa) e ricostruirli in un apposito diagramma (matrix). Questa lettura non è sempre facile perchè se è vero che lo strato recente normalmente copre quello antecedente, in molti casi può essere distanziato dal primo, situato in un altro settore dello scavo e addirittura a un livello più profondo. Va poi sempre considerato il ruolo delle unità negative che possono complicare ulteriormente il discorso.
La documentazione comporta in primo luogo la redazione di piante di strato (fig. 11). Di ogni unità positiva viene rappresentata in una pianta a sé stante l’interfaccia, cioè la superficie superiore nella sua massima estensione orizzontale. Il rilievo viene eseguito nel momento in cui l’interfaccia è stata completamente liberata dagli strati più recenti che la coprivano. Una volta terminato il disegno si procede allo scavo dello strato fino a mettere in luce l’interfaccia dell’unità successiva che sarà oggetto di un nuovo rilievo e rappresentata su un’altra planimetria. Nella pianta viene riportato il contorno dello strato con una linea continua, si indicano le quote altimetriche di alcuni punti per dare conto di eventuali pendenze, si disegnano i materiali visibili in superficie — ceramica, frammenti di tufo, tegole, ecc. La posizione di alcuni reperti particolari, come ad esempio le monete, può essere indicata con un asterisco e un numero che rimanda ad una scheda. Il profilo delle unità negative che hanno tagliato lo strato viene segnato con una linea a tratteggio. Il limite del saggio di scavo che interrompe la visione dell’interfaccia è reso con una linea a tratto-punto. Sulla pianta si riporta il numero assegnato allo strato (numero di US) ed eventualmente anche quello delle unità negative.
Nel corso dello scavo può essere opportuno, ai fini di una migliore comprensione del contesto, produrre anche delle piante composite che sono rappresentazioni d’insieme; per cui uno o più strati di cui sia stata completamente liberata l’interfaccia sono mostrati insieme agli strati sottostanti visibili solo in parte. Un’importante pianta composita è quella di fine scavo che fotografa quanto è visibile sul terreno alla fine dei lavori - strutture murarie, fosse ed eventuali strati di terra non scavati - documentando le fasi più antiche (fig. 12).
Sono tipiche dello scavo archeologico anche la sezione cumulativa e la sezione in parete (fig. 11). Entrambe mostrano in elevato la sovrapposizione delle unità stratigrafiche, identificate da una successione di linee continue corrispondenti ai profili altimetrici delle singole interfacce. Le sezioni cumulative passano in mezzo allo scavo e vengono disegnate a più riprese. Il profilo altimetrico di ogni strato viene disegnato subito dopo aver effettuato il rilievo della pianta. La sezione sarà aggiornata con i profili delle unità sottostanti man mano che queste saranno portate in luce. Altrimenti la sezione cumulativa può essere frutto di una elaborazione successiva che ricostruisce i profili degli strati sulle base delle quote riportate sulle piante.
La sezione in parete illustra la stratigrafia visibile su un lato della trincea. E’ una veduta laterale di tipo prospettico e il rilievo può essere effettuato in un’unica tornata alla fine dei lavori. E’ giusto definirla sezione e non prospetto perché gli strati sono visibili in quanto tagliati verticalmente dallo scavo. Nella sezione vengono disegnati i materiali contenuti all’interno degli strati così come appaiono sulla parete della trincea.
Una struttura muraria può essere composta da più strati, ciascuno dei quali corrisponde a una determinata fase della costruzione. Ad esempio potrebbe comprendere un muro in opera reticolata a cui un secolo dopo si è appoggiato un muro in opera laterizia, all’interno del quale dopo cinquant’anni è stata ricavata una finestra. In questo caso abbiamo una struttura costituita da due unità positive — i muri — e da un’unità negativa — il taglio della finestra. Le unità stratigrafiche murarie (USM) possono corrispondere anche a una normale sequenza di azioni connessa alla costruzione dell’edificio (fasi di cantiere) avvenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra: prima si getta la fondazione, poi si alza la parete, infine si costruisce la volta di copertura.
Di regola le unità stratigrafiche murarie vanno documentate alla stregua delle altre US e quindi rappresentate su singole piante di strato, soprattutto nel caso in cui esse dovranno essere demolite, l’una dopo l’altra, per poter scendere in profondità. Nella prassi gli edifici messi in luce dagli scavi vengono rappresentati su un’unica pianta dall’alto, comprensiva delle varie fasi costruttive, che quindi è una pianta composita (fig. 12). Se le pareti si conservano per un’altezza considerevole si può prevedere anche una pianta sezionata a una quota significativa. I muri vengono unitariamente considerati anche su una serie di prospetti e di sezioni-prospetto impostati con i criteri che abbiamo illustrato nel primo paragrafo e che derivano dai sistemi di rappresentazione del rilievo architettonico tradizionale (fig. 13).
Nel rilievo archeologico assume in ogni caso un’importanza centrale la lettura stratigrafica della parete. Nel disegno gli elementi che vanno prima di tutto chiaramente distinti, evidenziandoli rispetto agli altri per mezzo di un segno più marcato, sono i contorni delle singole unità stratigrafiche murarie (figg. 12, 13). Secondariamente — seguendo un ordine gerarchico che trova corrispondenza nella progressiva diminuzione dello spessore del segno — andranno considerati all’interno delle varie USM i profili di elementi architettonici che legano con quelli adiacenti e quindi sono stati costruiti nella stessa fase (ad esempio un timpano a mattoni messo in opera insieme alla cortina laterizia che gli sta a fianco); in terzo luogo verranno i contorni dei singoli elementi del materiale da costruzione (i cubilia dell’opera reticolata, i mattoni dell’opera laterizia, gli scapoli del conglomerato, ecc.); in ultimo eventuali segni di caratterizzazione che danno conto dell’usura e delle asperità dei materiali. Questa gerarchia va considerata anche nel rilievo degli strati di terra, per lo meno su tre livelli: prima il limite dello strato, poi il contorno dei materiali, infine il dettaglio all’interno dei materiali.
Agli ultimi due livelli di dettaglio si può attribuire nella scala 1:20 una funzione descrittiva che serve a far comprendere la composizione dei materiali dello strato o la tecnica edilizia del muro (caratterizzazione). Non necessariamente questi elementi devono essere rilevati uno per uno. Devono però riuscire a tradurre nella maniera più efficace, attraverso una resa di tipo naturalistico, le caratteristiche peculiari della superficie rappresentata.
Nei prospetti i paramenti murari vanno disegnati entro una griglia di costruzione che sia rispettosa del modulo reale (fig 13, v. cap. 10 fig.77a). Non è obbligatorio misurare le lunghezze dei singoli mattoni o blocchetti di tufo. Questi potranno essere schizzati rapidamente a occhio in mezzo alle linee di costruzione tenendo conto di alcune caratteristiche generali, come lo spessore e la lunghezza media dei vari elementi o il livello di erosione dei contorni. I marcapiani laterizi vanno invece misurati con precisione, comprese le lunghezze dei bipedali. Ugualmente vanno misurati i contorni dei paramenti murari. Bisogna poi fare attenzione che non vi siano scarti significativi nel valore del modulo tra una parta e l’altra della parete — come accade frequentemente nelle murature tardo-antiche e medievali — perché in questo caso andranno rilevati gli spessori dei singoli ricorsi.
E’ utile semmai integrare la documentazione in scala 1:20 con delle campionature di limitate porzioni delle varie pareti, effettuate con grande precisione tramite rilievi a contato in scala 1:1 (v. Cap. 3) oppure con il procedimento di raddrizzamento fotografico (v. Cap. 6).
I conglomerati, sia in pianta che in prospetto, vanno caratterizzati in modo che sia comprensibile il tipo di materiale utilizzato nel nucleo (fig. 6). I frammenti di laterizi saranno ad esempio chiaramente distinguibili dalle schegge di tufo per il contorno più spigoloso e lievemente più marcato. Allo stesso modo bisogna cercare di rendere chiara in pianta la differenza tra i materiali usati nel paramento, in modo che l’opera incerta non si confonda con la reticolata e l’opera laterizia con i tufelli della vittata. Il profilo di questi elementi nella vista dall’alto spesso non è molto evidente in quanto sono semicoperti dalla malta; il disegno invece deve farli risaltare di più per far capire di che materiali si tratta (fig. 12 A, B, C). Nelle malte e nei conglomerati di intonaci e pavimenti vanno distinti innanzitutto i contorni dei vari strati. La caratterizzazione servirà a dare idea delle dimensioni e la densità degli inclusi i quali aumentano di consistenza negli strati più profondi (figg. 14 D, 15 B).
Nei pavimenti vanno misurati con precisione i contorni delle lastre marmoree, i motivi decorativi dei mosaici, i bipedali allettati nella preparazione (fig. 15 C), le impronte nella malta delle lastre asportate (fig. 15 E). L’opus spicatum verrà disegnato tenendo conto della larghezza media delle file di mattoncini. I mosaici monocromi possono essere rappresentati con una caratterizzazione leggera che lasci intravedere l’orientamento e il modulo delle tessere; eventuali fasce di mosaico nero saranno più dense di segni rispetto al mosaico bianco (figg. 14 C, 15 B).
Per alcuni tipi di pietra (travertino, marmi venati, brecce) si può dare una resa naturalistica della trama naturale che le rende immediatamente identificabili. Altre, come i tufi, sarà inevitabile rappresentarle con delle simbologie più astratte che saranno indicate in legenda (fig.15 F, M). La caratterizzazione del materiale non deve però interferire con i profili di altri elementi (cornici, riseghe) rendendoli poco riconoscibili. In alcuni casi sarà più interessante documentare le tracce di lavorazione piuttosto che indicare la tipologia della pietra, di cui si darà eventualmente nota a parte (fig. 15 H).
Superfici curvilinee come le absidi o le volte a botte vengono rese efficacemente addensando i segni di caratterizzazione in modo graduale verso le parti viste di sguincio (il centro della curva se sezionata nel mezzo, i due estremi nella visione prospettica) (figg. 6 n. 1, 16a). Le ombreggiature non vanno completamente rifiutate nel rilievo archeologico; spesso aiutano a identificare buchi, rientranze e sporgenze. L’importante è che non siano invasive coprendo importanti dettagli e appesantendo un disegno già fin troppo caratterizzato. Sono pertanto da evitare le ingombranti proiezioni scure conformi alla teoria delle ombre. Saranno sufficienti poche file di puntini o una serie di trattini obliqui lungo il bordo in risalto; ci si potrà semmai attenere alla regola tradizionale per cui la luce viene sempre da un punto in alto a destra. Ai fini della chiarezza del disegno è bene però tenere presente quanto segue: due elementi adiacenti, ad esempio le lastre di una pavimentazione (figg. 14 A, 15 C, F) oppure un muro che si è affiancato a una struttura di fase precedente (fig. 12 H), vanno rappresentati con due linee distinte, mentre un elemento che si sovrappone a un altro coprendolo parzialmente oppure un elemento in primo piano che lega con quello in secondo piano (ad esempio la parasta nella veduta prospettica), si disegnano con una sola linea che sarà un po’ più marcata per evidenziare il dislivello; l’ombreggiatura è facoltativa.
Negli strati di terra la caratterizzazione serve innanzitutto a dare conto della densità, delle dimensioni e della composizione dei materiali che vi sono contenuti, fattori che possono variare tra una parte e l’altra dello strato. I materiali degli strati di crollo vanno misurati con maggiore precisione in quanto il rilievo potrà servire per la ricostruzione dell’alzato. Conviene in genere rilevare i contorni degli elementi di maggiori dimensioni i quali faranno da guida per inserire a occhio la caratterizzazione dei materiali in frantumi (fig. 11). In casi particolari — ad esempio frammenti di intonaci dipinti — sarà necessario passare a una scala più grande e lavorare col la massima accuratezza.
I dislivelli particolarmente pronunciati vengono convenzionalmente indicati nelle piante che rappresentano strati di terra, buche e fosse con dei segni grafici, denominati hachures o peli di pendenza, costituiti da un triangolino che si appoggia al bordo superiore della scarpata e prosegue con una linea fino al limite inferiore (fig. 15 G). Aumentando la pendenza si infittiscono le hachures nel disegno. In alternativa nelle piante molto caratterizzate le pendenze possono essere rese in maniera naturalistica con una trama di linee ad andamento orizzontale come le curve di livello, in gran parte disegnate a occhio, le quali diano l’idea delle asperità e degli scoscendimenti del terreno (figg. 12 F, 15 D). Questo tipo di trattamento grafico viene normalmente adoperato per rappresentare i dislivelli prodotti dall’erosione nelle creste murarie in opera cementizia e più in generale in tutti i materiali edilizi. Sulle piante archeologiche vanno comunque sempre riportate una serie di quote altimetriche (sul livello del mare o riferito a un sistema locale), indicate con un numero sopra un punto o un triangolino. Queste andranno messe soprattutto in prossimità dei dislivelli significativi (figg. 11, 12).
La muratura moderna e di restauro va sempre ben distinta da quella antica. Conviene in genere lasciarla in bianco (figg. 5; 16a). Nel caso fosse necessario segnalare interventi di restauro eseguiti in epoche diverse si possono utilizzare simbologie astratte molto leggere come ad esempio delle campiture in grigio uniforme. Un muro moderno che copre una parte dei resti archeologici si può anche contornare con una linea tratto-punto la quale indica un limite di scavo o un ingombro.
Sono solo pochi esempi delle tante situazioni in cui ci si può imbattere operando nel campo del rilievo archeologico. Servono anche a far comprendere che le modalità di rappresentazione non devono essere ingabbiate entro regole troppo rigide, ma occorre spesso decidere caso per caso proponendosi come risultato la massima chiarezza espositiva e la massima precisione in relazione alle finalità del rilievo. E’ un lavoro che in definitiva richiede sensibilità, intelligenza e buone competenze come archeologi.
Un’accortezza da rispettare in tutti i rilievi archeologici, anche in altre scale, è quella di rendere sempre evidente per mezzo del trattamento grafico la differenza tra i profili che corrispondono alla forma originale degli elementi e quelli che invece proiettano il contorno di superfici usurate. In molti casi questo non si può tradurre con un diverso spessore del segno. Si consideri ad esempio il contorno di un muro in pianta il quale in alcuni tratti corrisponde alla facciavista del paramento, in altri, dove questo è stato asportato, al profilo del nucleo cementizio. Non si può variare lo spessore della linea perché questa identifica il limite dell’unità stratigrafica distinguendola con molta chiarezza, proprio grazie a un segno relativamente più marcato, rispetto alle strutture circostanti. In tal caso allora conterà soprattutto lo stile della linea la quale sarà tracciata in maniera più dritta e regolare per riprodurre il tratto conservato della parete e con un segno ondulato nei tratti che identificano le asperità dell’opera cementizia. A volte non è facile seguire questo accorgimento; ci sono situazioni che richiedono un’attentissima osservazione e una notevole abilità manuale come è il caso ad esempio della decorazione architettonica dove bisogna riuscire a identificare le parti sane dei profili curvilinei delle modanature da quelle scheggiate e usurate. Eppure è molto importante tenere sempre in conto questo fattore perché una delle finalità principali del rilievo è quella di fornire una rappresentazione dell’oggetto che sia depurata dalle ambiguità dell’osservazione visiva. In taluni casi è ammissibile qualche forzatura rispetto al dato reale pur di rendere comprensibile il contesto documentato.
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei dati il rilievo diretto ha un ruolo assolutamente centrale di cui daremo conto nel prossimo capitolo. Il rilievo indiretto con la stazione totale o il teodolite è comunque molto utile per creare una rete di punti d’appoggio. Fotografie raddrizzate con i metodi della fotogrammetria monoscopica possono in taluni casi agevolare la caratterizzazione delle superfici.
Si adatta per la rappresentazione di edifici articolati in vari ambienti oppure per estesi scavi archeologici che hanno messo in luce vasti insiemi (una villa, un lungo segmento stradale, una serie di fosse di coltivazione, una necropoli di tombe a fossa) in modo che possano essere contemplati in un numero limitato di elaborati grafici, se non in un’unica tavola.
La documentazione di scavo della scala 1:50 seguirà gli stessi criteri della scala 1:20. Delle strutture murarie si darà una lettura stratigrafica secondo i principi sopra esposti. La caratterizzazione è ancora di tipo naturalistico, ma più sintetica e con un maggiore livello di astrazione (figg. 15, 16a). Nei muri la rappresentazione dei materiali tende a utilizzare delle simbologie uniformi, anche se di tipo realistico, universalmente diffuse per identificare le varie tecniche edilizie. I bipedali, le ammorsature presso gli angoli, i blocchi dell’opera quadrata o dell’opera poligonale vanno in ogni modo misurati e rappresentati con precisione allo stesso modo dei contorni delle unità stratigrafiche e di tutti gli elementi architettonici (cornici, mensole, scalini, piattabande, archi di scarico, ecc.). Anche nella scala 1:50 gli elementi adiacenti andrebbero rappresentati con due linee distinte. Si può però sintetizzare la caratterizzazione delle tecniche edilizie, pur nel rispetto del modulo, disegnando i letti di malta dei paramenti murari in prospetto con una sola linea(fig. 16a).
Anche per la realizzazione di elaborati grafici in scala 1:50 è fondamentale il procedimento del rilievo diretto. A latere l’inquadramento topografico con il teodolite o la stazione risulterà comunque indispensabile.
Questi rapporti di scala si prestano per inquadrare in un’unica planimetria vasti complessi archeologici e monumentali. Nella maggior parte dei casi sono il frutto di rielaborazioni di piante più dettagliate in scala 1:20 e 1:50 che vengono georeferenziate e ricomposte per essere ridisegnate in modo schematico. Si riprendono i contorni dei muri e dei tagli più importanti (canali, sepolture, tracciati stradali, ecc.) semplificando il segno e tralasciando la caratterizzazione archeologica. I nuovi elaborati in scala più piccola avranno funzione di piante d’insieme. Dei riquadri rettangolari potranno eventualmente rinviare alle piante di dettaglio (v. Cap. 11, fig. 85).
Queste planimetrie più schematiche possono essere adoperate per fornire delle informazioni che sintetizzano quelle già contenute nelle piante di dettaglio oppure per proporre delle interpretazioni che sono il risultato dello studio e dell’analisi del contesto rilevato.
Nella pianta d’insieme, utilizzando una grafica diversa, potranno ad esempio essere nuovamente indicate le tecniche costruttive dei muri. Si tralasceranno inevitabilmente molti dettagli — ammorsature angolari, piccole risarciture di fase successiva - ma il vantaggio sarà quello di restituire una visione unitaria del complesso edilizio.
L’analisi dei dati del rilievo consente di produrre i seguenti elaborati:
Piante tematiche. Vi sono indicate le tipologie degli oggetti riportati in pianta (ad esempio muri, canali, strade, tombe, pozzi, cisterne ecc.) (v. Cap. 11, figg. 84, 85).
Piante di fase. Indicano la cronologia delle varie parti del complesso archeologico messo in luce, databili in base ai rapporti stratigrafici, ai materiali contenuti negli strati, alle tecniche edilizie dei muri. Le cronologie possono essere assolute (I sec. a.C., I sec. d.C, ecc.) oppure — se gli unici elementi sicuri sono i rapporti stratigrafici - relative (I fase, II fase, ecc.) (v. Cap. 9, fig. 63b).
Piante ricostruttive. Propongono un’ipotesi ricostruttiva della forma originaria dei manufatti rilevati (fig. 17). La ricostruzione planimetrica può essere estensiva, suggerendo la prosecuzione di muri o altri elementi in determinate direzioni e per una certa lunghezza, ma può anche formulare una restituzione dell’alzato di un edificio sulla base delle tracce rinvenute nelle fondazioni (ipotizzare ad esempio l’esistenza di un colonnato sul muro di fondazione messo in luce dallo scavo).
Nei tipi di planimetrie sopra elencati si usano simbologie astratte in bianco e nero o a colori, le quali campiscono gli oggetti da descrivere, costituite da insiemi di linee e simboli grafici di vario tipo (tratteggi) che vengono tradotti in legenda (fig. 16b). La computer grafica incoraggia l’uso del colore consentendo di differenziare gli oggetti del disegno con campiture a tinte piatte oppure, più rapidamente, colorando le sole linee di contorno.
Nelle simbologie astratte che descrivono le tecniche edilizie andrebbero adottati tipi di tratteggi relativamente standardizzati a livello internazionale i quali sono stati già indicati in varie pubblicazioni sul rilievo. Per le piante tematiche e di fase c’è completa libertà di scelta. Nelle piante ricostruttive a piccola scala si usa in genere una campitura nera per indicare le strutture conservate, mentre i muri ipoteticamente ricostruiti sono delimitati da due linee continue e restano bianchi all’interno. Su questo tema fondamentale si innestano diverse varianti. Per quanto riguarda i resti conservati alcuni autori usano un tratteggio a linee diagonali per i muri ed evidenziano in nero le colonne; qualcuno opera anche una distinzione tra fondazioni e alzati, questi ultimi più scuri. Le strutture ricostruite sono in molti casi delimitate da due linee a trattini, anziché continue, oppure si distinguono le proposte ricostruttive quasi sicure (a linea continua) da quelle probabili (a trattini) (fig. 17).
L’ambito delle scale 1:200 e 1:500 indicato per questo tipo di elaborazioni è chiaramente indicativo. Planimetrie che riportano in modo schematico il profilo dei muri sono leggibili almeno fino alla scala 1:2000. In altri casi piante di fase e piante ricostruttive possono richiedere un maggiore dettaglio ed essere pertanto redatte in scala più grande. Le piante di fase utilizzano talvolta come base i rilievi originali in scala 1.20 e 1:50 i quali vengono campiti con stesure di colore semitrasparente che lascia intravedere la caratterizzazione archeologica. Ovviamente si possono prevedere non solo piante ma anche sezioni-prospetto sia ricostruttive che di fase. Molto diffuse sono sempre state anche le ricostruzioni assonometriche. Oggi si ricavano da modelli tridimensionali creati al computer per mezzo dei programmi di grafica; ma la tradizionale pianta ricostruttiva in bianco e nero resta tutt’oggi uno strumento insuperato, di rapida esecuzione e di immediata comprensione. Si consideri d’altra parte che per quanto riguarda le strutture rinvenute negli scavi archeologici nella stragrande maggioranza dei casi le informazioni sull’elevato restano assai generiche, per cui diventa possibile soltanto proporre una ricostruzione planimetrica.
Le piante archeologiche a piccola scala di tipo urbanistico o territoriale sono elaborate, nella maggior parte dei casi, utilizzando planimetrie realizzate da altri soggetti e in genere di pubblico dominio le quali descrivono il contesto topografico odierno (ad esempio mappe catastali, aerofotogrammetrie, tavolette IGM). Su queste vengono posizionati i resti archeologici già noti che possono essere dedotti da altre planimetrie oppure quelli individuati in occasione di scavi o ricognizioni recenti. Questa impostazione di base accomuna le mappe, in scala relativamente più grande (1:000/1:5000), alle carte topografiche che sono in scala più piccola (1:10.000/1:200.000). Sono differenti però le modalità di rappresentazione grafica tra le une e le altre, che sono dovute alla differenza di scala, ma anche i metodi di acquisizione dei dati.
Uno dei più importanti esempi di piante archeologiche urbane, che tutt’ora costituisce un modello nella sua modernità, è la Forma Urbis Romae di Rodolfo Lanciani pubblicata tra il 1893 e il 1901 (fig. 18). L’opera in scala 1:1000 è composta da 46 tavole dove, sulla base della pianta moderna di Roma, in colore rosa pallido, sono riportati i contorni di tutti i monumenti antichi e medievali noti a quell’epoca, molti dei quali erano appena stati messi in luce dai grandi lavori di trasformazione della nuova capitale. Il livello di dettaglio è tale da mostrare muri, pilastri e colonne degli edifici antichi. Le strutture che sono state realmente individuate sul territorio sono in nero, le ipotesi ricostruttive sono in bianco secondo le convenzioni sopra illustrate. I basolati stradali sono addirittura caratterizzati con una simbologia naturalistica.
Negli anni scorsi la Forma Urbis del Lanciani è stata informatizzata e inserita in un GIS gestito dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma — Nuova Forma Urbis -, sovrapposta a una aerofotogrammetria vettoriale della città attuale, aggiornata con i dati acquisiti dalle recenti ricerche e interfacciata con una serie di carte storiche in formato raster. Questa impostazione è tipica delle mappe archeologiche a scala urbana realizzate nel nostro tempo. I dati archeologici provengono da piante di tipo diverso e a scala diversa (carte storiche e rilievi recenti), con una veste grafica quindi assai eterogenea, le quali vengono informatizzate e georeferenziate al computer con programmi e procedure che esamineremo nei capitoli seguenti. Le basi più utilizzate sono mappe catastali o planimetrie di derivazione aerofotogrammetrica. La cartografia catastale italiana, gestita attualmente dall’Agenzia del Territorio, comprende poco più di 200.000 fogli dei quali nel 2003 almeno 180.000 erano stati già acquisiti in formato raster, mentre 100.000 erano disponibili anche in formato vettoriale. Le mappe anteriori al 1946 utilizzano il sistema di coordinate Cassini-Soldner, quelle posteriori il Gauss-Boaga come la cartografia dell’Istituto Geografico Militare (cfr. Cap. 5).
Per consentire l’inserimento dei resti antichi all’interno di questo tipo di mappe i rilievi in scala 1:20 o 1:50 vanno prima georeferenziati sul campo utilizzando strumentazioni topografiche come il GPS o la stazione totale. Perlomeno andranno agganciati a spigoli di edifici adiacenti che sono riportati sulle planimetrie della città moderna.
In questo ambito la base più utilizzata dagli archeologi in Italia è quella delle carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare. La vecchia serie, ancora in uso, è costituita da 278 fogli in scala 1:100.000 che coprono l’intero territorio nazionale, a ciascuno dei quali corrispondono quattro quadranti in scala 1:50.000 designati da numeri romani, a loro volta suddivisi in quattro tavolette in scala 1:25.000 denominate dai punti cardinali (NE, SE, SO, NO). Ogni carta è identificata anche da un titolo che corrisponde a un toponimo della zona inquadrata, generalmente il nome della città più importante. La sua posizione è riportata in un quadro d’unione che può essere consultato sul sito internet dell’Istituto. Le carte sono vendute sia in formato cartaceo che vettoriale. Sono in corso aggiornamenti mediante stereorestituzioni e sono state create delle nuove serie.
Le carte dell’IGM sono riferite al sistema di proiezione nazionale Gauss-Boaga e dal 1950 anche al sistema internazionale UTM, che è allineato al primo e le cui coordinate sono riportate lungo i bordi. Vi sono rappresentati i confini amministrativi, l’orografia a curve di livello, fiumi e altri elementi del paesaggio insieme a strade, centri urbani e numerosi tipi di manufatti sparsi sul territorio. Molte sono state aggiornate di recente, altre mostrano ancora un contesto antropico che risale a qualche decennio fa e che nel frattempo ha subito profonde trasformazioni. Le tavolette in scala 1:25.000, dato il loro maggiore livello di dettaglio, sono generalmente preferite per il posizionamento delle evidenze archeologiche (fig. 19). Queste vengono indicate facendo ricorso prevalentemente a simboli grafici che servono a identifi-care un punto della carta (cerchi, triangoli, asterischi), i quali hanno un significato tematico o cronologico di cui si dà conto nella legenda (fig. 20). Siti relativamente ampi, dei quali a questa scala sono ancora apprezzabili le dimensioni, possono essere segnati con una linea di contorno che corrisponde al perimetro reale campita con un tratteggio. Le linee sono adoperate anche per identificare manufatti di considerevole lunghezza come mura, strade, canali artificiali.
Alla cartografia dell’Istituto Geografico Militare si è affiancata negli ultimi decenni un’imponente produzione a opera di enti locali e istituzioni di vario tipo, anche soggetti privati, la quale non copre sistematicamente l’intero territorio nazionale ma che in molti casi può risultare utile e anche sostitutiva delle tavolette IGM ai fini dell’inquadramento delle evidenze archeologiche, soprattutto nei casi in cui la scala è più grande e garantisce quindi un maggiore livello di dettaglio. Vanno segnalate fra le altre le Carte Tecniche Regionali (CTR) realizzate negli ultimi decenni in varie scale, dall’1:5000 all’1:10.000, su base aerofotogrammetrica.
Si utilizzano infine anche le fotografie aeree: i fotopiani che sono strisciate di foto aeree raddrizzate, di solito in scala più grande delle carte topografiche, come ad esempio quelle che compongono gli Atlanti delle città italiane; le ortofotocarte, realizzate anche dall’IGM in scala 1:5000 e 1:10.000, costituite da fotogrammi aerei ad alta risoluzione che vengono ortorettificati e georeferenziati. Si usano inoltre foto satellitari (Landsat, Quickbird e altre), molte delle quali liberamente scaricabili da internet.
La cartografia viene oggi gestita al computer per mezzo di programmi GIS che consentono di sovrapporre carte del territorio a varie scale e di diverso tipo, anche tematiche (ad esempio geologiche, idrografiche, statistiche,ecc.), con le foto aeree e satellitari. I dati vengono acquisiti dall’elaborazione di piante già esistenti ma anche organizzando apposite ricognizioni sul territorio finalizzate a individuare evidenze ancora non conosciute o non documentate le quali verranno posizionate con il GPS. Un apporto fondamentale è dato dall’analisi delle fotografie aeree le quali consentono di riconoscere importanti tracce sul terreno indirizzando la ricerca.
L’uso della computer grafica porta per molti versi a sminuire il significato che è stato tradizionalmente attribuito ai rapporti di scala. Oggi ci siamo abituati ad elaborare all’interno dei GIS planimetrie che hanno scale e formati originali completamente differenti. Alle carte che rappresentano vaste porzioni del territorio sovrapponiamo piante di dettaglio degli scavi archeologici che riproducono anche oggetti molto piccoli; usando gli zoom siamo in grado in un istante di passare dalla visione dell’uno a quella dell’altro contesto. Tutti i disegni vettoriali, sia nei CAD che nei GIS, vengono inoltre scalati al rapporto 1:1 allo scopo di facilitare le procedure di georeferenziazione e di allineamento e per renderli facilmente misurabili.
Tuttavia ragionare in termini di scale grafiche ha ancora una grande importanza per alcune fondamentali ragioni. La prima è che nell’ambito della documentazione archeologica il procedimento del rilievo diretto ha un ruolo centrale e ineliminabile. Questo comporta che si lavori sul campo secondo i metodi tradizionali disegnando su un foglio le cui dimensioni saranno commisurate a quelle del contesto da rappresentare. Se per mezzo di uno strumento topografico prendiamo le misure di una serie di punti che serviranno a facilitare le operazioni di rilievo diretto otterremo per prima cosa un file vettoriale georeferenziato e in scala 1:1, ma poi da questo dovremo ricavare una tavola stampata da portare sul campo dove i punti siano inquadrati alla scala che utilizziamo per disegnare in modo da potervi sovrapporre la pianta a matita (cfr. Cap. 4).
La seconda ragione è che gli elaborati grafici finali realizzati al computer sono quasi sempre destinati ad essere stampati e in alcuni casi pubblicati. Si consideri che le riproduzioni cartacee delle planimetrie trovano ancora una larga diffusione nei cantieri, essendo utilizzate da una pluralità di operatori per effettuare controlli, prendere decisioni e apportarvi le necessarie annotazioni. Il livello di dettaglio dovrà pertanto tenere conto del formato del foglio di carta destinato a contenere il disegno. I diversi tipi di grafica che sono stati indicati nel paragrafo precedente hanno una logica in quanto ciascuno di essi può essere apprezzato adeguatamente solo se il relativo supporto cartaceo rispetti, almeno in linea di massima, quel determinato rapporto di scala.
Le dimensioni degli elaborati cartacei devono adeguarsi a dei formati standard internazionali (in Italia denominati formati UNI) che corrispondono a quelli delle stampanti, degli scanner e delle fotocopiatrici. Nell’ambito del rilievo si usano quelli compresi tra l’A0 e l’A4 di cui diamo qui di seguito le specifiche: A0 = 841 x 1189 mm ; A1 = 594 x 841 mm ; A2 = 420 x 594 mm ; A3 = 297 x 420 mm ; A4 = 210 x 297 mm. I disegni di piccole dimensioni è vantaggioso riuscire a contenerli nei formati A3 o A4 per poter usufruire di macchinari a basso costo. Le dimensioni dell’A0 non vanno superate di troppo. Per l’altezza dei fogli c’è un limite massimo di 914 mm, che corrisponde all’apertura della maggior parte dei plotter e degli scanner professionali (questa misura viene definita A0+); se la stampa è su rullo si può abbondare di più sulla misura dell’altro lato (oltre i 1189 mm).
I disegni vettorializzati ci danno il grande vantaggio di poter apprezzare al computer, in unico file, planimetrie dettagliate di contesti molto ampi senza alcun limite di estensione. Tuttavia occorre prevedere la stampa di questi elaborati. Un foglio A0 potrebbe non essere sufficiente per contenere la pianta di uno scavo o di un edificio. Allora sarà necessario programmare per mezzo del software di grafica le dimensioni delle tavole da stampare, componendo un quadro d’unione con dei criteri razionali che cerchino di assicurare per quanto è possibile la visione unitaria di determinati settori (v. Cap. 11, fig. 85). Coloro che preferiscono ancora oggi lucidare i disegni a matita con il rapidograph dovranno comporre questi quadri d’insieme lavorando più scomodamente su un grande tavolo. In questi casi se è previsto un rilievo strumentale in appoggio al rilievo diretto, è utile programmare il taglio delle piante definitive in fase di elaborazione del file dei punti topografici: vi corrisponderà il formato delle tavole dei punti da portare in cantiere e sulle quali saranno sovrapposti i fogli per il disegno a matita.
La scelta tra la scala 1:20 e la scala 1:50, che va fatta prima di iniziare il rilievo, è condizionata molte volte dalle dimensioni del contesto da documentare in previsione della sua rappresentazione sugli elaborati cartacei definitivi. Non ha molto senso ad esempio pensare di documentare in scala 1:20 un complesso monumentale della grandezza delle Terme di Caracalla se il risultato finale sarà una esagerata frammentazione del rilievo in una grande quantità di tavole, ove in molti casi non si riuscirà a comprendere in un A0 l’intero perimetro di un ambiente. In una situazione del genere la scala 1:50, che comunque garantisce un più che accettabile livello di dettaglio per il rilievo archeologico-architettonico, risulterà la scelta più idonea. Per determinati settori che meritano una più accurata lettura si potranno eventualmente preventivare in aggiunta delle tavole di dettaglio a scala più grande. In ogni caso andrà prodotta anche una pianta d’insieme in scala 1:200 o 1:500 per poter inquadrare l’intero edificio.
Ai rapporti di scala sono correlati inoltre i valori di tolleranza degli errori di misurazione del disegno. Secondo la regola tradizionale il limite della approssimazione grafica (o errore di graficismo) è stabilito dalla più piccola misura che l’occhio umano è capace di apprezzare su un foglio di carta, la quale corrisponderebbe a 0,2 mm. Quindi rispetto alle dimensioni reali degli oggetti rilevati saranno tollerati errori più grandi verso le scale piccole, errori più piccoli verso le scale grandi.
Il limite di 0,2 mm si traduce rispetto alle scale più comunemente utilizzate nel rilievo nelle seguenti misure reali:
- cm. ± 0,2 di errore nella scala 1:10
- cm. ± 0,4 di errore nella scala 1:20
- cm. ± 1 di errore nella scala 1:50
- cm. ± 4 di errore nella scala 1:200
Questi valori potrebbero sembrare privi di senso nella grafica vettoriale, dove un errore pari a un centimetro reale può apparire smisuratamente grande oppure restare invisibile a seconda di come viene ingrandita l’immagine sullo schermo. E’ invece assolutamente necessario tenerne conto in previsione del formato definitivo del disegno.
Nel rilievo archeologico si aggiungono ulteriori tolleranze in relazione agli oggetti rappresentati. Il limite convenzionalmente stabilito va sicuramente rispettato per la misurazione di tutti i profili che corrispondono al limite originario degli elementi architettonici. Nella caratterizzazione o nei contorni degli strati di terra saranno accettabili anche scostamenti maggiori. L’importante come sempre è saper fare un ragionamento. In un prospetto l’irregolare profilo superiore del nucleo cementizio di una parete in rovina non necessiterà di esser misurato in ogni punto con maniacale pignoleria, ma lo si potrà disegnare in buona parte a occhio sulla base di alcuni riferimenti situati nell’intorno. Tuttavia anche in casi del genere non bisogna dimenticarsi dell’elementare assunto logico per cui la presenza di una struttura nega l’esistenza di un vuoto. Se ci sono ragioni per ritenere che in origine sopra la cresta diruta poteva starci una fila di finestre, delle quali non resta più alcuna traccia, il punto più alto conservato del muro andrà misurato con maggiore esattezza perché ci restituirà la quota minima ipotizzabile per i davanzali
.
Nei primi due paragrafi abbiamo dato conto di alcuni segni grafici che sono entrati nell’uso universale (fig. 4). Riassumendo i tipi di linee ricordiamo:
Le linee tratto-punto indicano: sulle piante il percorso delle sezioni; sulle sezioni gli agganci alle linee tratto-punto tracciate in pianta; i limiti di saggio e i contorni di ingombri di qualunque tipo che impediscono la visione di una parte del disegno.
Le linee tratto-due punti indicano l’aggancio con una struttura disegnata su un’altra pianta.
Le linee tratteggiate segnalano: la proiezione di elementi architettonici situati sopra il piano secante, comprese le volte di copertura, e di quelli che stanno sotto il piano secante ma non sono visibili; i tagli nelle piante di strato; la prosecuzione di un muro di cui si interrompe la visuale; le ipotesi ricostruttive.
Quest’ultime però vanno evitate nei rilievi, i quali devono dare una rappresentazione oggettiva. Se un grafico comprende linee dello stesso tipo e con diversi significati, queste andranno differenziate nella lunghezza dei trattini o nello spessore e se ne darà eventualmente conto in legenda.
Nel disegno manuale della tavola definitiva (lucidatura) si usano pennini (rapidograph) di diverso spessore; lavorando in CAD gli spessori delle linee vengono impostati in funzione della stampa. La grossezza della punta tiene conto dei rapporti gerarchici tra i vari tipi di linea, che abbiamo già indicato e che possono essere riassunti secondo questo ordine:
- Linea di sezione
- Limiti di unità stratigrafiche, anche murarie.
- Limiti tra elementi architettonici in fase
- Contorni dei materiali che fanno parte dell’unità stratigrafica
- Caratterizzazione interna ai materiali
Per quanto riguarda le punte da utilizzare nei vari casi, il cui spessore viene espresso in frazioni del millimetro, non ci sono rigide regole prestabilite. La sezione deve risaltare nettamente e quindi sarà maggiore la differenza di dimensioni tra questo tipo di segno e il successivo, che non fra gli altri quattro, ma senza neanche esagerare troppo la grossezza del primo perché altrimenti non sarebbero apprezzabili i dettagli del muro secato. Una proposta ragionevole è la seguente: 0,6 mm per la sezione e rispettivamente 0,3 mm, 0,2 mm, 0,15 mm, 0,1 mm per gli altri segni. I segni grafici di vario tipo — tratteggi, linee tratto-punto, ecc. — possono essere tracciati con la punta di 0,2 mm. che è quasi uno standard nel disegno tecnico. Nei rilievi di edifici i contorni dei vuoti (porte, finestre) e quelli degli avancorpi dovrebbero avere il necessario risalto anche se sono in fase con le strutture adiacenti, quindi è adatto il pennino da 0,3 mm.
Lo spessore della linea di sezione, le cui dimensioni non sono indifferenti ai fini della comprensione della misura reale del muro, nei disegni con il rapidograph veniva tracciato subito all’interno del segno a matita che definisce con esattezza il profilo della parete; ma ormai nelle stampe dei disegni elaborati in CAD viene a trovarsi inevitabilmente sull’asse della linea. Nel rilievo architettonico l’ingombro del muro secato viene fatto ulteriormente risaltare con un tratteggio obliquo sia in pianta che in sezione. Nei rilievi archeologici redatti in questi ultimi trent’anni si è perduta in parte questa abitudine per non appesantire grafici già molto caratterizzati, ma anche perché nel disegno a mano libera comportava una notevole perdita di tempo. In alcuni casi può avere un senso diversificare i tratteggi all’interno della linea di sezione per identificare le tecniche edilizie dei muri; si potranno utilizzare le simbologie astratte che abbiamo indicato trattando dei disegni in scala 1:200 e 1:500 (fig. 16b).
La linea di sezione andrebbe inoltre interrotta, per un brevissimo tratto, quando taglia due strutture diverse e non in fase, corredata da trattini ortogonali che accennano il profilo delle due superfici affiancate (fig. 15 C). Questo distacco troverà corrispondenza nella eventuale proiezione dei due elementi sul prospetto, i cui contorni andranno disegnati con due linee distinte.
Gli elaborati definitivi vanno inoltre tutti corredati da una serie di simboli grafici che qui sotto indichiamo. Chi disegna in CAD dispone di un apposito ambiente operativo, denominato layout di stampa, che serve a configurare l’aspetto finale dei disegni destinati alla stampa.
Sulle piante vanno indicati i percorsi delle sezioni con linee a tratto-punto corredate da frecce che indicano la direzione del punto di vista e coppie di lettere che identificano le singole sezioni (fig. 4). Sulle sezioni vanno segnalati i punti di aggancio con le piante, che corrispondono alle frecce alle due estremità ed eventualmente a baionette e angoli intermedi, con appositi segni grafici, ad esempio linee a tratto-punto verticali (fig. 5). Devono essere inoltre riportate presso i margini laterali del foglio almeno una coppia di tacche che indicano una quota altimetrica di riferimento, sul livello del mare o locale (figg. 3, 5, 11).
Sulle piante si aggiungono quote altimetriche nei punti significativi indicate con un punto o un triangolo ed eventualmente, in caratteri un po’ più grandi, i numeri di US e USM (fig. 12). Nei rilievi a scala più grande la legenda non è obbligatoria se la caratterizzazione naturalistica è in grado di “parlare da sola”.
Le piante d’insieme di scavi ed edifici, devono essere orientate e georeferenziate, riportando i valori delle coordinate in corrispondenza di tacche lungo la cornice, come è uso della cartografia. Per quanto è possibile anche le planimetrie in scala più grande, in particolare quelle 1:50, si conformeranno a tali convenzioni. Nelle scale grandi tuttavia (particolarmente 1:10 e 1:20) conviene in molti casi orientare la pianta con il manufatto rappresentato, soprattutto per risparmiare spazio (fig.10). L’importante è che l’esatta collocazione spaziale di questi elaborati sia rintracciabile all’interno di quadri d’unione georeferenziati. Questo discorso si riferisce ovviamente alle tavole cartacee. Nel CAD saranno orientati e georeferenziati tutti i disegni.
Anche nei casi in cui la tavola sia parametrata con le coordinate spaziali vanno sempre riportati la bussola del nord e la scala grafica in previsione di una sua possibile pubblicazione.
Il committente richiederà in determinati casi la redazione di un cartiglio, da apporre all’esterno della cornice del disegno, in cui saranno riportate una serie di indicazioni tra cui ad esempio il nome della Soprintendenza Archeologica e del funzionario responsabile, oltre a vari dati che identificano il contenuto della tavola. Ritengo sia assolutamente doveroso riportare sempre il nome dell’autore del rilievo, soprattutto in caso di rilievo diretto, e quello di chi ha eseguito l’elaborazione grafica definitiva, quindi non solamente, come purtroppo accade spesso, quello della società che ha avuto in appalto il lavoro. E’ una questione di trasparenza per il committente e di rispetto verso un professionista che si prenderà la responsabilità del risultato e a cui vanno riconosciuti il diritto d’autore e il valore intellettuale della sua opera.
Tutti gli elaborati definitivi dei rilievi archeologici possono essere eseguiti in CAD oppure a mano libera utilizzando i rapidograph. Ciascuno deve essere libero di seguire questa o quell’altra strada in base alle sue capacità e competenze personali. Qualunque disegno eseguito a mano libera potrà essere in un secondo momento scansionato e vettorializzato, anche da un altro professionista. Il CAD, da parte sua, consente oggi di eseguire qualunque tipo di disegno e renderlo assolutamente irriconoscibile nello stile, una volta stampato, rispetto a un grafico a mano libera, come è il caso di tante immagini pubblicate in questo testo. Quello che conta è il risultato finale nel quale andranno presi in considerazione fondamentalmente due fattori, più che la gradevolezza del disegno sul piano estetico: l’esattezza del rilievo e una rappresentazione chiara del contesto documentato, nel rispetto di determinate convenzioni e pienamente adeguata alle esigenze di lettura e di analisi dei manufatti antichi. Il committente prima di affidare un incarico di questo tipo dovrà pertanto valutare non tanto i mezzi che verranno utilizzati dal professionista contattato quanto la sua capacità di adempiere alle finalità sopra indicate.
|
figura 1
Figura 2
figura 3
figura 4
figura 5
figura 6
figura 7
figura 8
figura 9
figura 10
figura 11
figura 12
figura 13
figura 14
figura 15a
figura 16a
figura 16b
figura 17
figura 18
figura 19
figura 20
|